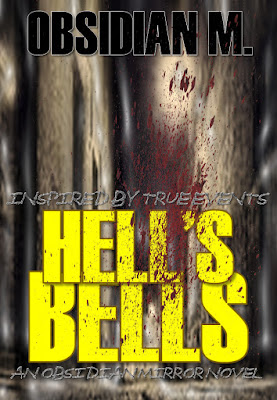Tra i tanti ricordi più o meno intensi che mi sono rimasti di me stesso bambino ce n'è uno in particolare che credo non mi lascerà mai. Molto di quello che sto per raccontarvi è offuscato dalle nebbie del tempo ma, grazie ad internet, sono ora in grado di mettere delle pezze sui dettagli che nel frattempo si sono volatilizzati dalla mia memoria, come ad esempio quale fosse la data esatta. Era la sera del 7 dicembre 1978, come poi ho scoperto in rete, e di conseguenza il bambino di allora aveva esattamente undici anni. Il mio papà, la mia mamma e io eravamo riuniti nella mia cameretta come ogni sera, perché era in quella stanza che troneggiava il mitico tubo catodico, rigorosamente in bianco e nero, che ci teneva compagnia. Io ero sdraiato nel mio lettino, dal quale riuscivo a scorgere a malapena lo schermo e nel quale spesso finivo per addormentarmi qualunque cosa succedesse attorno a me. Mia mamma era sul divano, un occhio alla televisione e l'altro adagiato sul lavoro a maglia che portava avanti ininterrottamente da un tempo inspiegabile. Mio papà preferiva una scomodissima sedia sulla quale si contorceva in posizioni impossibili ma che, a suo dire, era mille volte più comoda del divano. Pance piene e luci spente perché quella sera, alle venti e quaranta, andava in onda sul secondo canale RAI il tanto atteso episodio della fortunatissima serie di film per la TV intitolata "Sette storie per non dormire".
Anni dopo, tornando a pensare a quella serata, l'unica cosa che mi sarebbe tornata alla mente, oltre alle sensazioni di puro terrore che, probabilmente per la prima volta in vita mia, provai, era appunto il titolo di quel ciclo di film. Addirittura, la mia mente aveva cancellato il dettaglio che si trattasse di veri e propri film: mi sembrava infatti di ricordare che si trattasse di una serie di brevi episodi della durata di un'ora, trasmessi in seconda serata. La confusione evidentemente era derivata dal fatto che in quella particolare sera fu trasmesso un film composto da tre episodi e che, fra i tre, quello che mi ricordavo io fosse l'ultimo della serie. Non ho alcun ricordo dei primi due episodi. Immagino che li guardai senza particolare interesse, magari tutto preso a pensare ai fatti miei, ma l'ultimo, mio Dio, l'ultimo fu qualcosa di agghiacciante.
Ricordavo questa bamboletta di legno dall'aspetto terrificante che aveva preso vita e che, brandendo un coltellaccio, inseguiva una ragazza nella sua casa. Ricordavo che quella bamboletta era stata definita "feticcio", termine che ancora oggi associo immediatamente a quel ricordo. C'era insomma questo feticcio che inseguiva la malcapitata ragazza da una stanza all'altra, dalla cucina alla camera da letto al bagno. Lei chiudeva le porte dietro di sé ma l'inseguitore, in un modo o nell'altro, riusciva ad avere la meglio su di esse. Lei ancora riusciva a chiudere il mostro dentro una valigia, ma il maledetto riusciva ad uscire praticando, dal suo interno, un foro circolare con la lama del coltello. Una tensione esagerata che sfido chiunque, a quell'età, a riuscire a sopportare. Chissà se i miei genitori si stavano rendendo conto della mia angoscia. Non l'ho mai capito. Fatto sta che quella notte dovetti pregarli di dormire nel lettone, desiderio che, ovviamente, e con mio grande disappunto, non fu soddisfatto. Un ricordo che mi ha accompagnato per tutta la vita sebbene, con il passare degli anni, i suoi contorni a poco a poco si siano sfumati. Come detto mi ricordavo solo del titolo della serie, "Sette storie per non dormire", e tanto mi bastò anni dopo, nell'era di internet, per ricostruire le parti mancanti.
Ed oggi eccomi finalmente qui a parlarne sul blog, nel contesto dell'iniziativa "Notte Horror" che alcuni accaniti cinefili stanno portando aventi nel tentativo di riprodurre le atmosfere delle celebri notti horror televisive di venti e più anni fa. Avrei voluto in realtà parlarne molto tempo fa e precisamente già nell'agosto del 2013, quando mi raggiunse la notizia della scomparsa di Karen Black, l'affascinante attrice che in "Trilogia del terrore" (questo il titolo di quel mitico film) offre il suo volto a ben quattro personaggi, ma poi la mia attenzione fu distolta da altre faccende e l'idea si tramutò in un nulla di fatto. Quest'anno però, complice il fatto che questo è il post di chiusura del crossover "Notte Horror", la mia scelta non poteva che ricadere su qualcosa di veramente speciale, un classico senza tempo. E quale migliore occasione per ripescare “Trilogia del terrore” di Dan Curtis (1975)?
Partiamo dal titolo che, come spiegherò più avanti, trovo abbastanza fuorviante. I termini orrore e terrore vengono spesso utilizzati come sinonimi (io stesso, per semplicità, lo faccio spesso) ma, in effetti, tecnicamente non lo sono. Come spiega in poche e semplici parole Antonello Sarno nel suo saggio “Il cinema dell’orrore”: "Nei fatti, ciascuno dei due generi comincia dove finisce l’altro, creando un’interdipendenza che sconfina con l’identificazione. Se il film horror consiste in un racconto basato prevalentemente sulla presenza di esseri mostruosi [...], la cinematografia del terrore fa invece riferimento a quei film in cui gli effetti raccapriccianti non derivano da creature in qualche maniera “fantastiche”, ma spiegabili sulla base delle nostre conoscenze razionali, come ad esempio le psicologie distorte. In sostanza, i film dell’orrore e del terrore sono due parti, o meglio due espressioni indissolubilmente connesse di quell’unicum fatto di razionalità e di fantasia, di calcolo e di pulsioni che altro non è se non il nostro cervello, misura terrena di tutte le cose, persino dei nostri terrori ed orrori quotidiani". In questo senso, essi non sarebbero altro che sottogeneri del macrogenere horror, parola inglese che racchiude in sé tutte le varie sfaccettature del perturbante.
A essere onesti, a livello contenutistico non c’è poi molto da dire in proposito: le trame, senza scadere nel banale, sono abbastanza semplici e tutte in qualche modo incentrate su figure femminili che, prima della fine, manifesteranno un lato oscuro. In un contesto del genere va da sé che gran parte del suo successo stia nell’avvalersi di una protagonista azzeccatissima (la già citata Karen Black), convincente tanto nei panni della seria professoressa del primo episodio (Julie) che in quelli delle gemelle del secondo (Thérèse e Millicent) dal contegno sociale all’estremo opposto (l’una disinibita e amorale, forse persino ninfomane, l’altra repressa e bigotta al limite del sopportabile) che, per finire, in quelli titubanti e ingenui della giovane donna del terzo episodio (Amelia) che fatica a staccarsi dall’ingombrante presenza della figura materna.
Il regista esplora e ci fa esplorare diverse varianti dell’orrore in cui i suoi personaggi sono calati, all’apparenza passando da quello di origine psicologica dei primi due episodi (causato, consapevolmente o meno, dalle stesse protagoniste) a quello soprannaturale del terzo, tanto più misterioso perché legato a un oggetto proveniente da un’altra cultura (quella degli Zuni, nativi americani appartenenti al popolo Pueblo). Ma è solo un gioco che si potrebbe ribaltare, ribaltando la stessa prospettiva dalla quale si prendono in esame i primi due racconti. Proviamoci.
Capitolo 1 - Una professoressa diventa l’oggetto delle attenzioni ossessive di un suo studente. Quando decide di concedergli un appuntamento Julie non sa che sta per finire in una spirale di orrore e paura… o sì? Molto spesso le cose non sono come sembrano, ma chi ci dice in effetti che il villain di questa storia sia un semplice essere umano? E se la sua astuzia e la sua perfidia avessero qualcosa di diabolico, o comunque di sovrannaturale? Anche se il regista non concede prove chiare né indizi, nulla ci vieta di interpretare la narrazione in tal senso e di annoverare l’episodio nel filone del fantastico. (E non è neanche detto che questo lo renda più terrificante. Da un demone o uno spirito non ci si aspetta altro che malvagità, ma l’esperienza insegna che la cattiveria umana può anche arrivare a superarla.)
Capitolo 2 - Due sorelle diverse come il giorno e la notte e fra loro un odio acuito, anche, da motivi economici (un’eredità da spartire): la collera di Millicent avrà conseguenze infauste. Thérèse si era davvero spinta ad allacciare rapporti incestuosi col padre quando era appena adolescente? Com’è possibile che gli uomini che la conoscevano, incluso il suo ultimo amante, s’innamorassero perdutamente di lei senza accorgersi della sua perversità? E Millicent invece era davvero quella povera infelice, succube della sorella e senza prospettive di una vita autonoma che voleva far credere? In effetti, le due si scopriranno legate anche più di quanto fosse possibile immaginare… Ricondurre anche questo racconto entro i limiti del fantastico sembra impresa difficile, eppure se pensiamo che il nostro nome definisce la nostra identità cosa può accadere a una persona che ha non uno, ma ben due nomi?
Capitolo 3 - Amelia è divisa fra la madre, che come ogni venerdì si aspetta che la giovane trascorra con lei la serata, e il fidanzato, che invece vorrebbe festeggiare con lei il compleanno che cade proprio quel giorno. Un inquietante feticcio Zuni, acquistato come regalo per quest’ultimo, si rivelerà il ricettacolo di un’entità maligna, un guerriero animato da una furia cieca e distruttrice. Uno spirito capace di cambiare corpo, trasformando la dolce Amelia in un essere che, per uno strano scherzo del destino, finirà per distruggere la sua vita e allo stesso tempo compensarla dei torti subiti.
La bambola-feticcio di “Amelia” è il vero, terrificante simbolo di questo lungometraggio, quello che più di qualsiasi altra cosa restò impresso ai telespettatori italiani di quel lontano 1978 al termine di quella singolare serata (e di ciò, come sapete, posso fornirne una testimonianza diretta). A perpetuarne il ricordo contribuì, a mio parere, il confronto con i primi due episodi, debolissimi in confronto alla magnificenza del terzo. Basato su un breve racconto di Richard Matheson (Prey, 1969), l'episodio "Amelia" contiene, a detta di molti, i "dieci minuti più terrificanti della storia del cinema", al punto da essere stato più volte preso ad esempio e imitato come nel caso, assolutamente evidente, di "Demoni 2" (1986) di Lamberto Bava. Vent'anni più tardi, infine, sarà lo stesso Dan Curtis a riproporre un sequel ufficiale, realizzando "Trilogia del terrore II" (1996) nel quale, oltre ai due soliti episodi introduttivi, riappare nuovamente il feticcio Zuni, ripreso esattamente dal punto in cui terminava il cult anni Settanta. Ma questa è un'altra storia.
Anni dopo, tornando a pensare a quella serata, l'unica cosa che mi sarebbe tornata alla mente, oltre alle sensazioni di puro terrore che, probabilmente per la prima volta in vita mia, provai, era appunto il titolo di quel ciclo di film. Addirittura, la mia mente aveva cancellato il dettaglio che si trattasse di veri e propri film: mi sembrava infatti di ricordare che si trattasse di una serie di brevi episodi della durata di un'ora, trasmessi in seconda serata. La confusione evidentemente era derivata dal fatto che in quella particolare sera fu trasmesso un film composto da tre episodi e che, fra i tre, quello che mi ricordavo io fosse l'ultimo della serie. Non ho alcun ricordo dei primi due episodi. Immagino che li guardai senza particolare interesse, magari tutto preso a pensare ai fatti miei, ma l'ultimo, mio Dio, l'ultimo fu qualcosa di agghiacciante.
Ricordavo questa bamboletta di legno dall'aspetto terrificante che aveva preso vita e che, brandendo un coltellaccio, inseguiva una ragazza nella sua casa. Ricordavo che quella bamboletta era stata definita "feticcio", termine che ancora oggi associo immediatamente a quel ricordo. C'era insomma questo feticcio che inseguiva la malcapitata ragazza da una stanza all'altra, dalla cucina alla camera da letto al bagno. Lei chiudeva le porte dietro di sé ma l'inseguitore, in un modo o nell'altro, riusciva ad avere la meglio su di esse. Lei ancora riusciva a chiudere il mostro dentro una valigia, ma il maledetto riusciva ad uscire praticando, dal suo interno, un foro circolare con la lama del coltello. Una tensione esagerata che sfido chiunque, a quell'età, a riuscire a sopportare. Chissà se i miei genitori si stavano rendendo conto della mia angoscia. Non l'ho mai capito. Fatto sta che quella notte dovetti pregarli di dormire nel lettone, desiderio che, ovviamente, e con mio grande disappunto, non fu soddisfatto. Un ricordo che mi ha accompagnato per tutta la vita sebbene, con il passare degli anni, i suoi contorni a poco a poco si siano sfumati. Come detto mi ricordavo solo del titolo della serie, "Sette storie per non dormire", e tanto mi bastò anni dopo, nell'era di internet, per ricostruire le parti mancanti.
Ed oggi eccomi finalmente qui a parlarne sul blog, nel contesto dell'iniziativa "Notte Horror" che alcuni accaniti cinefili stanno portando aventi nel tentativo di riprodurre le atmosfere delle celebri notti horror televisive di venti e più anni fa. Avrei voluto in realtà parlarne molto tempo fa e precisamente già nell'agosto del 2013, quando mi raggiunse la notizia della scomparsa di Karen Black, l'affascinante attrice che in "Trilogia del terrore" (questo il titolo di quel mitico film) offre il suo volto a ben quattro personaggi, ma poi la mia attenzione fu distolta da altre faccende e l'idea si tramutò in un nulla di fatto. Quest'anno però, complice il fatto che questo è il post di chiusura del crossover "Notte Horror", la mia scelta non poteva che ricadere su qualcosa di veramente speciale, un classico senza tempo. E quale migliore occasione per ripescare “Trilogia del terrore” di Dan Curtis (1975)?
Partiamo dal titolo che, come spiegherò più avanti, trovo abbastanza fuorviante. I termini orrore e terrore vengono spesso utilizzati come sinonimi (io stesso, per semplicità, lo faccio spesso) ma, in effetti, tecnicamente non lo sono. Come spiega in poche e semplici parole Antonello Sarno nel suo saggio “Il cinema dell’orrore”: "Nei fatti, ciascuno dei due generi comincia dove finisce l’altro, creando un’interdipendenza che sconfina con l’identificazione. Se il film horror consiste in un racconto basato prevalentemente sulla presenza di esseri mostruosi [...], la cinematografia del terrore fa invece riferimento a quei film in cui gli effetti raccapriccianti non derivano da creature in qualche maniera “fantastiche”, ma spiegabili sulla base delle nostre conoscenze razionali, come ad esempio le psicologie distorte. In sostanza, i film dell’orrore e del terrore sono due parti, o meglio due espressioni indissolubilmente connesse di quell’unicum fatto di razionalità e di fantasia, di calcolo e di pulsioni che altro non è se non il nostro cervello, misura terrena di tutte le cose, persino dei nostri terrori ed orrori quotidiani". In questo senso, essi non sarebbero altro che sottogeneri del macrogenere horror, parola inglese che racchiude in sé tutte le varie sfaccettature del perturbante.
A essere onesti, a livello contenutistico non c’è poi molto da dire in proposito: le trame, senza scadere nel banale, sono abbastanza semplici e tutte in qualche modo incentrate su figure femminili che, prima della fine, manifesteranno un lato oscuro. In un contesto del genere va da sé che gran parte del suo successo stia nell’avvalersi di una protagonista azzeccatissima (la già citata Karen Black), convincente tanto nei panni della seria professoressa del primo episodio (Julie) che in quelli delle gemelle del secondo (Thérèse e Millicent) dal contegno sociale all’estremo opposto (l’una disinibita e amorale, forse persino ninfomane, l’altra repressa e bigotta al limite del sopportabile) che, per finire, in quelli titubanti e ingenui della giovane donna del terzo episodio (Amelia) che fatica a staccarsi dall’ingombrante presenza della figura materna.
Il regista esplora e ci fa esplorare diverse varianti dell’orrore in cui i suoi personaggi sono calati, all’apparenza passando da quello di origine psicologica dei primi due episodi (causato, consapevolmente o meno, dalle stesse protagoniste) a quello soprannaturale del terzo, tanto più misterioso perché legato a un oggetto proveniente da un’altra cultura (quella degli Zuni, nativi americani appartenenti al popolo Pueblo). Ma è solo un gioco che si potrebbe ribaltare, ribaltando la stessa prospettiva dalla quale si prendono in esame i primi due racconti. Proviamoci.
Capitolo 1 - Una professoressa diventa l’oggetto delle attenzioni ossessive di un suo studente. Quando decide di concedergli un appuntamento Julie non sa che sta per finire in una spirale di orrore e paura… o sì? Molto spesso le cose non sono come sembrano, ma chi ci dice in effetti che il villain di questa storia sia un semplice essere umano? E se la sua astuzia e la sua perfidia avessero qualcosa di diabolico, o comunque di sovrannaturale? Anche se il regista non concede prove chiare né indizi, nulla ci vieta di interpretare la narrazione in tal senso e di annoverare l’episodio nel filone del fantastico. (E non è neanche detto che questo lo renda più terrificante. Da un demone o uno spirito non ci si aspetta altro che malvagità, ma l’esperienza insegna che la cattiveria umana può anche arrivare a superarla.)
Capitolo 2 - Due sorelle diverse come il giorno e la notte e fra loro un odio acuito, anche, da motivi economici (un’eredità da spartire): la collera di Millicent avrà conseguenze infauste. Thérèse si era davvero spinta ad allacciare rapporti incestuosi col padre quando era appena adolescente? Com’è possibile che gli uomini che la conoscevano, incluso il suo ultimo amante, s’innamorassero perdutamente di lei senza accorgersi della sua perversità? E Millicent invece era davvero quella povera infelice, succube della sorella e senza prospettive di una vita autonoma che voleva far credere? In effetti, le due si scopriranno legate anche più di quanto fosse possibile immaginare… Ricondurre anche questo racconto entro i limiti del fantastico sembra impresa difficile, eppure se pensiamo che il nostro nome definisce la nostra identità cosa può accadere a una persona che ha non uno, ma ben due nomi?
Capitolo 3 - Amelia è divisa fra la madre, che come ogni venerdì si aspetta che la giovane trascorra con lei la serata, e il fidanzato, che invece vorrebbe festeggiare con lei il compleanno che cade proprio quel giorno. Un inquietante feticcio Zuni, acquistato come regalo per quest’ultimo, si rivelerà il ricettacolo di un’entità maligna, un guerriero animato da una furia cieca e distruttrice. Uno spirito capace di cambiare corpo, trasformando la dolce Amelia in un essere che, per uno strano scherzo del destino, finirà per distruggere la sua vita e allo stesso tempo compensarla dei torti subiti.
La bambola-feticcio di “Amelia” è il vero, terrificante simbolo di questo lungometraggio, quello che più di qualsiasi altra cosa restò impresso ai telespettatori italiani di quel lontano 1978 al termine di quella singolare serata (e di ciò, come sapete, posso fornirne una testimonianza diretta). A perpetuarne il ricordo contribuì, a mio parere, il confronto con i primi due episodi, debolissimi in confronto alla magnificenza del terzo. Basato su un breve racconto di Richard Matheson (Prey, 1969), l'episodio "Amelia" contiene, a detta di molti, i "dieci minuti più terrificanti della storia del cinema", al punto da essere stato più volte preso ad esempio e imitato come nel caso, assolutamente evidente, di "Demoni 2" (1986) di Lamberto Bava. Vent'anni più tardi, infine, sarà lo stesso Dan Curtis a riproporre un sequel ufficiale, realizzando "Trilogia del terrore II" (1996) nel quale, oltre ai due soliti episodi introduttivi, riappare nuovamente il feticcio Zuni, ripreso esattamente dal punto in cui terminava il cult anni Settanta. Ma questa è un'altra storia.
Accennavo all'inizio al'iniziativa blogghesca che cerca di ripescare nelle atmosfere delle celebri notti horror televisive di venti e più anni fa. L'estate è quasi finita e le "notti horror" sono ormai già alle nostre spalle ma, se ne avete voglia, siete ancora in tempo a recuperare ciò che è già stato trasmesso altrove sui blog amici. Questo post è infatti l'ultimo della serie: sono stati già pubblicati articoli su grandi cultoni horror del passato quali Il conte Dracula, The Wicker Man, Cujo, La mosca, The Devil Rides Out, Candyman, Hellraiser, Brood, la covata malefica, Buio Omega, Big Bad Wolves, Cimitero vivente, Suspiria, Nightmare, dal profondo della notte, Giovani streghe, Coraline e la porta magica, Quella villa accanto al cimitero e, giusto un paio d'ore fa, Dead Snow.